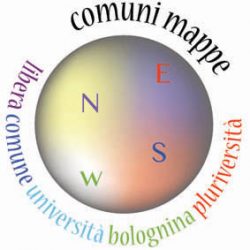Settimo Convivio dedicato a Ivan Illich
Bologna, sabato 30 novembre – domenica 1 dicembre 2013
Presso l’HUB di via Luigi Serra 2/G, Bologna
Organizza: Banca del Tempo Momo con la collaborazione di Comunimappe
Sabato dalle ore 10 con pausa pranzo conviviale (ognuno può contribuire portando qualcosa da bere o da mangiare) – Domenica dalle ore 10 alle ore 13
Interverranno
Jean-Michel Corajoud (Cercle des lecteurs d’Ivan Illich, Losanna, Svizzera): Ivan Illich e l’autonomia secondo la parabola del Samaritano
Andrea Sedini (San Feliciano sul lago Trasimeno): Intorno a “Non ci indurre nel diagnostico, ma liberaci dalla ricerca della salute” – Lettera di Illich a Manfredo Pace per il Simposio “Malattia e salute come metafore sociali” (Bologna 25-28 ottobre 1998) – Il corpo cibernetico come non corpo.
Adele Cozzi, Gabriella Orsi, Maria Messina, Daniela Conti (gruppetto di amici di Marzabotto e dintorni: Una pagina di Illich da leggere
Luigi Finelli: Illich e Platone – Riflessioni di uno s-docente di filosofia
Claudio Orrù e Matteo Chinosi (Varese): Beni comuni? Commons? Ambiti di comunità? – La difficoltà di descrivere il “fare comune” attraverso il linguaggio odierno
Pino De March (Comunimappe, Bologna): Illich, Marx, Polanyi e i Beni Comuni
Paolo Bosco (Comunimappe, Bologna): Il gigante dalle gambe di argilla non può fallire – Oltre il concetto di morfologia applicato alla realtà sociale, Illich e la sua eredità oggi.
Giusi Lumare (Banca del Tempo Momo, Bologna): Pratiche sociali di reciprocità
Salvatore Panu: Pratiche dell’autogestione collettiva ed estorsione istituzionale
Parteciperanno inoltre
Aldo Zanchetta (Lucca), Moreno Morara (San Lazzaro di Savena), Mauro De Filippo (Bologna) ed altr*…
———————————
APPROFONDIMENTI
DISOCCUPAZIONE CREATIVA
Ivan Illich
Prefazione.
Nell’ultimo decennio ho preparato e pubblicato un certo numero di saggi (1) sul modo di produzione industriale. Durante questo periodo mi sono soprattutto occupato dei processi attraverso i quali una crescente dipendenza da beni e servizi prodotti in serie elimina a poco a poco le condizioni necessarie per una vita conviviale.
Ciascun saggio, nell’esaminare un settore diverso della crescita economica, dimostra una regola generale: i valori d’uso vengono ineluttabilmente distrutti quando il modo di produzione industriale raggiunge quel predominio che io ho chiamato monopolio radicale. Questo saggio e quelli che lo precedono descrivono in che modo la crescita industriale produce la versione moderna della povertà. Questo tipo di povertà fa la sua apparizione quando l’intensità della dipendenza dal mercato arriva a una certa soglia. Sul piano soggettivo, essa è quello stato di opulenza frustrante che s’ingenera nelle persone menomate da una schiacciante soggezione alle ricchezze della produttività industriale. Essa non fa altro che privare le sue vittime della libertà e del potere di agire autonomamente, di vivere in maniera creativa; le riduce a sopravvivere grazie al fatto di essere inserite in relazioni di mercato. Questo nuovo tipo d’impotenza, proprio perché vissuta a un livello così profondo, difficilmente riesce a trovare espressione. Siamo testimoni di una trasformazione appena percettibile del linguaggio corrente, per cui verbi che una volta indicavano azioni intese a procurare una soddisfazione vengono sostituiti da sostantivi che indicano prodotti di serie destinati a un mero consumo passivo: imparare, per esempio, diventa acquisto di un titolo di studio.
Traspare da questo un profondo cambiamento dell’immagine che gli individui e la società si fanno di se stessi. E non è solo il profano che fa fatica a descrivere con precisione ciò che avverte. L’economista di professione non sa riconoscere quella povertà che i suoi strumenti convenzionali non sono in grado di rilevare.
Il nuovo fattore di mutazione dell’impoverimento continua tuttavia a diffondersi. L’incapacità, peculiarmente moderna, di usare in modo autonomo le doti personali, la vita comunitaria e le risorse ambientali infetta ogni aspetto della vita in cui una merce escogitata da professionisti sia riuscita a soppiantare un valore d’uso plasmato da una cultura. Viene così soppressa la possibilità di conoscere una soddisfazione personale e sociale al di fuori del mercato.
Io sono povero, per esempio, una volta che per il fatto di abitare a Los Angeles o di lavorare al trentacinquesimo piano abbia perduto il valore d’uso delle mie gambe. Questa nuova povertà generatrice d’impotenza non va confusa col divario fra i consumi dei ricchi e dei poveri, sempre maggiore in un mondo in cui i bisogni fondamentali sono sempre più determinati dai prodotti industriali.
Tale divario è la forma che la povertà tradizionale assume in una società industriale, e che i termini tradizionali della lotta di classe adeguatamente mettono in luce e riducono. Distinguo altresì la povertà di tipo moderno dai prezzi gravosi imposti dalle esternalità che gli accresciuti livelli di produzione rigettano nell’ambiente. E’ chiaro che questi tipi di inquinamento, di tensione e di carichi fiscali sono ripartiti in maniera ineguale, e che in maniera altrettanto ineguale sono distribuite le difese da tali depredazioni. Ma, come i nuovi divari in fatto di accesso, anche queste iniquità dei costi sociali sono aspetti della povertà industrializzata per i quali è possibile trovare indicatori economici e verifiche oggettive. Non è così invece per l’impotenza industrializzata, che colpisce indifferentemente ricchi e poveri. Dove regna questo tipo di povertà, è impedito o criminalizzato qualsiasi modo di vivere che non dipenda da un consumo di merci. Fare a meno di consumare diventa impossibile, non soltanto per il consumatore medio ma persino per il povero. A nulla servono tutte le varie forme di assistenza sociale, dalle azioni positive alla formazione professionale. La libertà di progettare e farsi a modo proprio la propria casa è soppressa, sostituita dalla fornitura burocratica di alloggi standardizzati. negli Stati Uniti come a Cuba o in Svezia. L’organizzazione dell’impiego, della manodopera qualificata, delle risorse edilizie, i regolamenti, i requisiti necessari per ottenere credito dalle banche, tutto porta a considerare l’abitazione come una merce anziché un’attività. Che poi questa merce sia fornita da un imprenditore privato o da un “apparatcik” (denominazione della burocrazia statale nel vecchio sistema sovietico – ndr), il risultato concreto è sempre lo stesso: l’impotenza del cittadino, la nostra forma, specificatamente moderna, di povertà.
Ovunque si posi l’ombra della crescita economica, noi diventiamo inutili se non abbiamo un impiego o se non siamo impegnati a consumare; il tentativo di costruirsi una casa o di mettere a posto un osso senza ricorrere agli specialisti debitamente patentati è considerato una bizzarria anarchica. Perdiamo di vista le nostre risorse, perdiamo il controllo sulle condizioni ambientali che le rendono utilizzabili, perdiamo il gusto di affrontare con fiducia le difficoltà esterne e le ansie interiori. Porterò l’esempio di come nascono oggi i bambini nel Messico: partorire senza assistenza professionale è divenuta una cosa impensabile per le donne i cui mariti hanno un impiego regolare e che possono perciò accedere ai servizi sociali, per marginali o inconsistenti che questi siano. Esse si muovono ormai in ambienti dove la produzione di bambini rispecchia fedelmente i modelli della produzione industriale. Tuttavia le loro sorelle che vivono nei quartieri dei poveri o nei villaggi degli isolati si sentono ancora perfettamente capaci di partorire sulle loro stuoie, senza sapere che rischiano una moderna imputazione di negligenza colposa nei confronti dei propri bambini. Man mano però che i modelli di parto promossi dai professionisti arrivano anche a queste donne indipendenti, vengono distrutti il desiderio, la capacità e le condizioni di un comportamento autonomo.
In una società industriale avanzata, la modernizzazione della povertà vuol dire che la gente non è più in grado di riconoscere l’evidenza quando non sia attestata da un professionista, sia egli un meteorologo televisivo o un educatore; che un disturbo organico diventa intollerabilmente minaccioso se non è medicalizzato mettendosi nelle mani di un terapista; che non si hanno più relazioni con gli amici e col prossimo se non si dispone di veicoli per coprire la distanza che ci separa da loro (e che è creata prima di tutto dai veicoli stessi).
Insomma veniamo a trovarci, per la maggior parte del tempo, senza contatti con il nostro mondo, senza possibilità di vedere coloro per i quali lavoriamo, senza alcuna sintonia con ciò che sentiamo.
Questo saggio è un poscritto al mio libro “La convivialità” (Mondadori, Milano, 1974; ora red edizioni, Como, 1993).
Rispecchia i cambiamenti avvenuti nel decennio trascorso, sia nella realtà economica sia nel mio modo d’intenderla. Parte dalla convinzione che si è avuto un aumento piuttosto notevole dei poteri non tecnici, cioè rituali e simbolici, dei nostri maggiori sistemi tecnologici e burocratici, con una corrispondente diminuzione della loro efficacia scientifica, tecnica e strumentale. Nel 1968 era ancora abbastanza facile liquidare ogni resistenza organizzata dei profani al dominio dei professionismo come un mero ripiegamento su fantasie romantiche, oscurantiste o snobistiche. La valutazione che io facevo allora dei sistemi tecnologici, guardando le cose dai basso e a lume di buon senso, appariva infantile o reazionaria ai leader politici dell’attivismo civico e ai professionisti radicali che accampavano il diritto alla tutela dei poveri in virtù dei loro specifici saperi.
La riorganizzazione della società industriale intorno a bisogni, problemi e soluzioni definiti da professionisti era ancora il criterio di valore comunemente accettato, implicito in sistemi ideologici, politici e giuridici che per altro verso erano in netta e talora violenta opposizione tra loro. Il quadro ora è cambiato. Oggi, simbolo di competenza tecnica avanzata e illuminata è la comunità, il quartiere, il gruppo di cittadini che, fiduciosi nelle proprie forze, si dedicano ad analizzare sistematicamente e di conseguenza a ridicolizzare i bisogni, i problemi e le soluzioni definiti sulle loro teste dagli agenti delle istituzioni professionali. Negli anni sessanta l’opposizione dei profani ai provvedimenti pubblici basati sulle opinioni degli esperti pareva ancora fanatismo antiscientifico. Oggi la fiducia dei profani nelle scelte politiche basate su tali opinioni è ridotta al minimo. Sono migliaia ormai coloro che fanno le proprie valutazioni e s’impegnano, con molti sacrifici, in un’azione civica sottratta a qualunque tutela professionale, procurandosi le informazioni scientifiche di cui hanno bisogno con sforzi personali e autonomi.
Rischiando a volte la pelle, la libertà e la rispettabilità, esprimono un nuovo e più maturo atteggiamento scientifico. Sanno, per esempio, che la qualità e la quantità delle prove tecniche bastanti per dire di no alle centrali nucleari, alla moltiplicazione delle unità di cura intensiva, all’istruzione obbligatoria, al controllo fetale a mezzo monitor, alla psicochirurgia, alle cure con elettroshock o all’ingegneria genetica sono tali che il profano può recepirle e utilizzarle. Dieci anni fa la scolarizzazione obbligatoria era ancora protetta da potenti tabù.
Oggi i suoi difensori sono quasi esclusivamente fra gli insegnanti, che ne dipendono per l’impiego, oppure tra gli ideologi marxisti che difendono i detentori di sapere professionali in una fantomatica battaglia contro la borghesia d’avanguardia.
Dieci anni fa i miti circa l’efficacia delle istituzioni sanitarie moderne erano ancora incontestati. Quasi tutti i testi di economia recepivano la convinzione che l’attesa di vita degli adulti fosse in aumento, che la cura del cancro procrastinasse la morte, che la disponibilità di medici avesse come risultato un più alto tasso di sopravvivenza infantile. Da allora a oggi, la gente ha scoperto ciò che le statistiche demografiche avevano sempre mostrato: che l’attesa di vita degli adulti non è cambiata in misura socialmente significativa nel corso delle ultime generazioni; che nella maggior parte dei paesi ricchi è oggi inferiore a quella del tempo dei nostri nonni, e persino a quella che si registra in molti paesi poveri.
Dieci anni fa era ancora un obiettivo prestigioso l’accesso universale alla scuola post-secondaria, all’istruzione per gli adulti, alla medicina preventiva, alle autostrade, a un villaggio globale imperniato sull’elettrodomestico. Oggi i grandi rituali “mitopoietici” organizzati intorno all’istruzione, ai trasporti, all’assistenza sanitaria e all’urbanizzazione sono stati in parte demistificati. Non sono stati però ancora abrogati. I costi occulti e gli accresciuti divari nei consumi sono aspetti certamente importanti della nuova povertà, ma io guardo soprattutto a un altro elemento concomitante della modernizzazione: il processo per cui non c’è pressoché nessuno che non veda erosa la propria autonomia, spenta la propria capacità di soddisfazione, appiattita la propria esperienza e frustrati i propri bisogni. Ho esaminato, per esempio, gli ostacoli che nell’intera società si oppongono alla presenza reciproca e che sono inevitabili effetti collaterali di un tipo di trasporto ad alta intensità di energia. Ho voluto definire i limiti di potenza dei veicoli a motore equamente usati per accrescere le possibilità di contatto tra le persone. Ho ovviamente constatato che le alte velocità impongono necessariamente un’impari distribuzione dei fastidi, del rumore, dell’inquinamento, nonché del godimento dei privilegi. Ma non è su questo che ho posto l’accento. Il mio discorso si accentra sulle internalità negative della modernità: l’accelerazione che fa sprecare tempo, l’assistenza sanitaria che produce malati, l’istruzione che istupidisce. La distribuzione ineguale dei benefici surrogati o l’ineguale imposizione delle loro esternalità negative non sono che corollari della mia tesi di fondo.
M’interessano in questi saggi le conseguenze dirette e specifiche della povertà modernizzata, la capacità dell’uomo di sopportarle e il modo per sfuggire alla nuova miseria. Io condivido con altre persone il desiderio profondo di maggiore giustizia. Sono assolutamente contrario all’ingiusta distribuzione di ciò che può essere genuinamente e piacevolmente condiviso. Ma in questi ultimi anni mi è parso necessario esaminare attentamente gli obiettivi di qualsiasi proposta redistributiva.
Oggi vedo il mio compito con maggiore chiarezza di quando cominciai a scrivere e parlare della mitopoiesi controproduttiva latente in ogni progetto industriale recente. Il mio scopo è stato quello di scoprire e denunciare la falsa ricchezza che è sempre ingiusta perché può avere soltanto effetti frustranti. Mediante questo tipo di analisi si può porre le basi della teoria che dovrebbe ispirare la rigenerazione sociale possibile per l’uomo del ventesimo secolo. Durante questi ultimi anni ho ritenuto necessario sottoporre a un riesame continuo la relazione tra la natura degli strumenti e il concetto di giustizia che prevale nella società che li adopera. Ho dovuto constatare come la libertà declini laddove i diritti sono formulati dagli esperti. Ho avuto modo di misurare che cosa comporta il cambio tra gli strumenti nuovi che spingono ad aumentare la produzione di merci, e quelli altrettanto moderni che permettono di generare valori col loro uso; tra il diritto a merci prodotte su scala di massa e il livello di libertà che permette un’espressione personale soddisfacente e creativa; tra l’impiego pagato e la disoccupazione utile. E in tutti gli aspetti di questa sostituzione della gestione “eteronoma all’attività” autonoma, mi accorgo quanto sia difficile recuperare un linguaggio che ci permetta di porre l’accento su quest’ultima.
Come i lettori ai quali intendo rivolgermi, sono un così convinto e impegnato sostenitore d’un accesso radicalmente equo ai beni, ai diritti e ai posti di lavoro che mi sembra quasi superfluo insistere sulla nostra battaglia per questo aspetto della giustizia. Trovo molto più importante, e più difficile, affrontare il suo complemento, la politica della convivialità. Uso questo termine nell’accezione tecnica che gli ho dato in La “convivialità”, intendendo cioè la lotta per un’equa distribuzione della libertà di generare valori d’uso, e per una strumentazione di tale libertà che sia ottenuta mettendo al primo posto assoluto la produzione di quei beni e servizi industriali e professionali che conferiscano ai meno avvantaggiati il massimo potere di generare valori nell’uso. Un indirizzo politico nuovo, conviviale, si fonda sulla convinzione che in una società moderna tanto la ricchezza quanto i posti di lavoro possono essere condivisi equamente e goduti nella libertà solo ponendo loro dei limiti mediante un processo politico. Forme eccessive di ricchezze e impieghi formali prolungati, per quanto ben distribuiti, distruggono le condizioni sociali, culturali e ambientali di un’eguale libertà produttiva. I “bit” e i “watt”, che qui vogliono dire, rispettivamente, le unità di informazione e di energia, se forniti sotto forma d’un qualunque prodotto di serie in quantità che superino una certa soglia-limite, diventano inevitabilmente ricchezza depauperante. La ricchezza o è troppo rara per poter essere spartita o distrugge la libertà e le libertà dei più deboli.
Con i miei saggi, ho cercato di dare un contributo al processo politico che deve portare i cittadini a riconoscere le soglie socialmente cruciali dell’arricchimento e a tradurle in tetti o limiti validi per l’intera società.
NOTE alla prefazione.
Nota 1: “Descolarizzare la società”, Mondadori, Milano, 1972.
“La convivialità”, Mondadori, Milano, 1974 (ora red edizioni, Como, 1993).
“Energia ed equità”, in “Per una storia dei bisogni”, Mondadori, Milano 1981.
“Nemesi medica”, Mondadori, Milano, 1977 (ora red edizioni, Como, 1991).